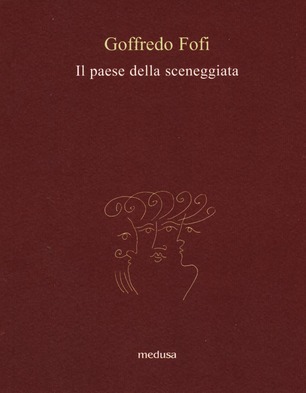19/10/1985 • In Texas apriva il primo negozio; oggi ne resta solo uno in Oregon
Bend è una città dell’Oregon, ai piedi della Catena delle Cascate, una catena di montagne che la separa dall’Oceano Pacifico. Conta quasi 100mila abitanti (un po’ meno di Piacenza). È una di quelle città americane che – se ho ben visto da Google Maps – si raggiunge dopo aver percorso per ore e ore una statale circondata da deserto e arbusti, con qualche conifera che segnala l’avvicinarsi dell’abitato. In città, si può fare qualche escursione e bere birra, bevanda a cui sono dedicati ben tre punti dei dieci must see nell’opuscolo turistico. Nulla di più; senonché, quasi all’incrocio tra la Route 97 e la Route 20, tra un negozio di cannabis e un crematorio per animali, c’è un negozio di noleggio di videocassette e dvd unico al mondo, che – ci scommetto – proprio in quell’opuscolo prima o poi verrà inserito. L’insegna è una grossa etichetta blu, inclinata e strappata su un lato, dentro la quale si legge, in una cornice gialla e dello stesso colore, la parola “Blockbuster”.
Blockbuster significa campione di incassi, anche se quel block (= quartiere) e buster (= distruttore) rimanda alla sua origine di sinistro ordigno bellico. Il negozio è gestito da Sandi Harding, una robusta signora di 48 anni, cresciuta a pizze surgelate e videocassette prese a noleggio, come ha raccontato al Guardian. Ci lavora dal 2004. Nell’ultimo anno, si è vista arrivare un ragazzo dalla Spagna e una coppia dall’altra parte degli USA. Il primo, che in patria lavorava proprio da Blockbuster, è scoppiato in lacrime mentre videochiamava il suo ex-capo, aggirandosi tra gli scaffali dei film. La coppia, invece, era arrivata perché il loro figlio “facesse l’esperienza di vederne uno”; hanno noleggiato un dvd, consapevoli che non avrebbero trovato un lettore di vhs; poi, in albergo, hanno scoperto che nemmeno il lettore dvd c’era e sono stati costretti a comprare uno. Il motivo della visita del ragazzo spagnolo e della coppia americana è questo: a Bend si trova l’ultimo negozio Blockbuster rimasto sulla faccia della Terra.
Ora però prendiamo il nastro, infiliamolo nello sportello del videoregistratore e riavvolgiamolo finché un suono secco e meccanico ci avvertirà di poterlo rivedere dall’inizio, dopo i primi secondi di sfarfallio. Era il 19 ottobre del 1985 e a Dallas, in Texas, apriva il primo Blockbuster. Il negozio vantava un inventario di 6mila videocassette. Andò bene fin da subito e il fondatore, David Cook, investì altri sei milioni di dollari in un altro. Nel 1987 al cofondatore Wayne Huizenga, che lo aveva inglobato nella sua società mutuandone il nome, venne l’idea del franchising e fu il boom: negli anni successivi si arrivò a un ritmo di apertura di uno ogni 24 ore. Lo stesso anno, Blockbuster vinse la causa contro Nintendo per guadagnarsi anche il noleggio dei videogiochi e cominciò ad acquisire le maggiori rivali americane, sbarcando in una trentina di paesi. Nel 1998 arrivarono i primi dvd e il nuovo CEO John Antioco non si fece trovare impreparato: acquistò dalla Warner Bros i diritti di esclusiva per il noleggio, con un anticipo di sei mesi su quelli di vendita.
Forte di questo successo – del passaggio indolore tra vhs e dvd – Antioco aveva riso in faccia a Marc Randolph, che gli aveva proposto di acquisire la sua ditta di noleggio di dvd per posta, al prezzo di 50 milioni di dollari. La ditta si chiamava Netflix. Troppo facile ripensare ora a come sarebbe potuta andare se avesse accettato. Basti dire, però, che proprio quel no convinse Randolph a puntare tutto su un’azienda di software con l’obiettivo di “distruggere Blockbuster”. A dirla tutta, possiamo scrivere tranquillamente che, anche senza Randolph, sarebbe andata allo stesso modo. L’inevitabile fine del supporto fisico nel settore avrebbe condannato comunque al fallimento un’azienda che aveva da sempre puntato su un prodotto materiale. Nel 2004, Blockbuster impegnava più di 84mila persone e aveva 9mila negozi fisici. Quindici anni dopo, di quell’impero non restava più quasi nessuna traccia.
Volendo essere un po’ enfatici, per chi è nato e vissuto tra il 1980 e il 2000, Blockbuster ha portato il cinema, d’essai o campione d’incassi, nel salotto di casa; o almeno, lo ha reso definitivamente domestico. Oltre ad aver generato un fenomeno di nostalgia precoce. Personalmente, ricordo con la giusta commozione le liti con mia sorella per i film da guardare, ma anche per i pop-corn al caramello (anziché al cioccolato, che preferiva ed allora esistenti solo da Blockbuster), così come la gara a chi avrebbe infilato nella buca del negozio di via Aselli, a Cremona, la vhs o il dvd da restituire. Ma ricordo anche la faccia di mio padre quando si accorgeva di non aver restituito in tempo i film presi la settimana prima (lo si poteva fare entro il lunedì, altrimenti si pagava una multa); oppure la tessera di plastica sottile che era sempre in bella vista nel portafoglio dei miei. E poi tanti, tantissimi sabati sera passati lì a scegliere i film che avremmo visto. Non ricordo, invece, la musica di attesa del centralino che, mi hanno detto altri nostalgici, era quella dei titoli di testa di Star Wars.
Quando la notizia della fine di Blockbuster si diffuse, in molti provarono a reagire. Lo showman John Oliver, ad esempio, cercò di salvarne uno in Alaska, regalando al negozio il sospensorio usato da Russel Crowe nel film Cinderella Man. Ricevuto il cimelio, il negozio ricominciò a funzionare, ma dopo pochi mesi fallì come gli altri. Ancora nel 2008, Blockbuster compariva in una famosa scena nel film Yesman con uno stralunato Jim Carrey al telefono. Un omaggio in anticipo alla futura scomparsa? Sarebbe stata una bella uscita di scena, quella; ma la verità è che le notizie di perdite, chiusure, liquidazioni e licenziamenti si susseguirono senza sosta fino alla bancarotta. In Italia, Blockbuster arrivò nel 1994 e fallì nel 2012. Lo stesso anno in cui molti, a Cremona, passando da viale Trento e Trieste, videro le saracinesche del negozio abbassate per sempre.
E il Blockbuster di Bend city? Se lo volete vedere, non dovete affrettarvi: l’azienda che detiene il marchio Blockbuster ha rinnovato la licenza d’uso al negozio; e il contratto d’affitto dei locali non scadrà prima di qualche anno. Sono in tanti, comunque, compreso il New York Times, a chiedersi come sia possibile che sopravviva. Qualcuno ha parlato di una zona particolarmente difficile da collegare a una rete internet veloce abbastanza per lo streaming; altri, invece, sostengono che sia dovuto al carattere cinefilo della città (dove si tengono ben due festival all’anno). Nel frattempo, il negozio vende non solo vhs e dvd ma anche magliette e merchandising nostalgici: insomma, Blockbuster sta entrando nella mitologia degli anni ’90, insieme allo skateboard e alle converse. Lo si potrebbe candidare a museo ufficiale di quegli anni e forse non passerà molto prima che lo diventi. Intanto, si sa che sarà oggetto di un documentario, che però potrà essere visto per volontà dei produttori solo su supporto fisico e a noleggio e non in streaming. No, certo che no: e se ve lo perderete al cinema, probabilmente basterà cercarlo su Netflix.
Il Piccolo di Cremona, 19 ottobre 2019