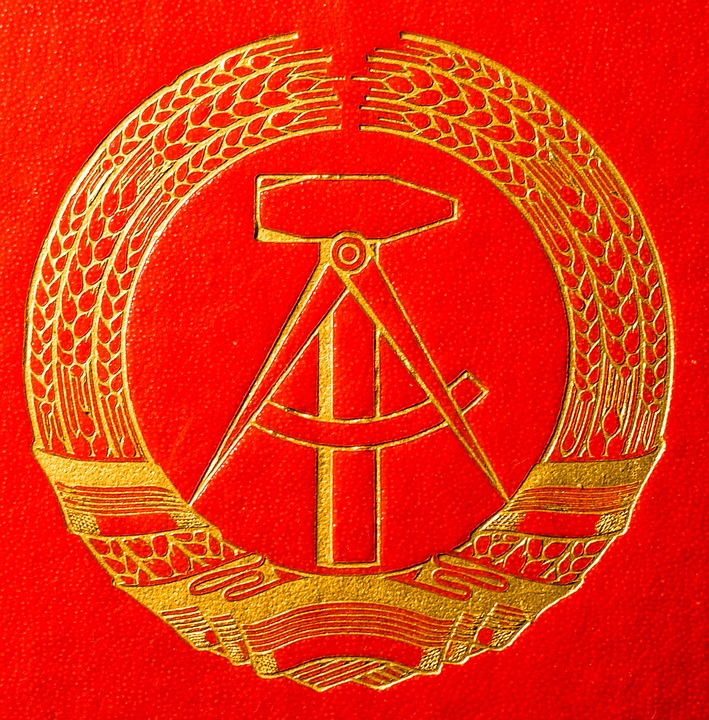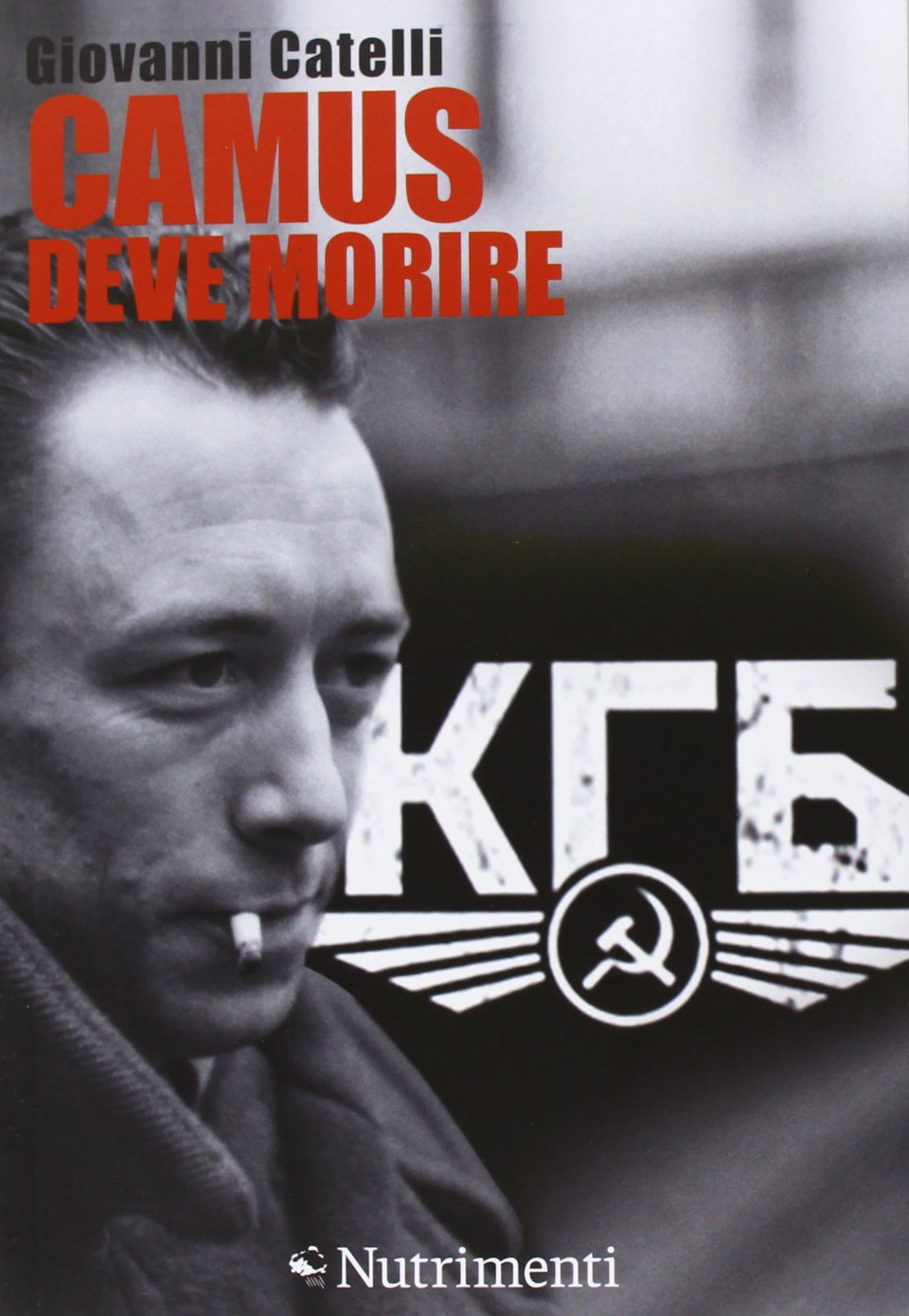7/3/1530 • Papa Clemente VII conferma la validità del primo matrimonio del sovrano, che sposa comunque Anna Bolena. La storia cambia
“The King’s great matter”, la “Gran Questione del re” (d’Inghilterra, naturalmente) fu ben più di un semplice divorzio. Anche perché il matrimonio in questione, quello tra Enrico VIII e Caterina d’Aragona, non era nato sotto i migliori auspici. “Se uno prende la moglie di suo fratello, è un’impurità, egli ha scoperto la nudità di suo fratello; non avranno figliuoli”. Così, il Levitico. E questo era il caso di Enrico: all’età di 23 anni, sposando Caterina, si era legato alla vedova del fratello Arturo, primogenito di Enrico VII di York. Il matrimonio era stato benedetto nel 1513 dalla bolla papale dall’energico Giulio II: un personaggio ben diverso da Clemente VII, il papa che quel 7 marzo 1530 prese una decisione destinata a cambiare la storia d’Europa: negare a Enrico l’annullamento della dispensa papale che lo aveva sposato.
Nonostante la benedizione divina, del resto, il matrimonio sembrava sul serio segnato dalla maledizione biblica: ai coniugi aveva portato solo figli morti e un’erede, Maria, con il difetto di essere donna. Un clima opprimente cominciava a serpeggiare a corte, sostituendosi a un periodo di grandi speranze. Per molti inglesi fu un gran sollievo vedere il nuovo re, appena diciassettenne, succedere nel 1509 al padre. Con l’appoggio dei suoi cancellieri, Enrico aveva tolto molte restrizioni che erano state imposte alla nobiltà e si era liberato di collaboratori impopolari. Era, del resto, il re, un uomo raffinato, che fin da bambino era stato preparato alla carriera ecclesiastica e, poi, a quella di regnante. Alto e robusto, solo verso i 40-50 anni avrebbe ceduto all’obesità. Danzatore, cacciatore, fu anche compositore di un certo talento: scrisse una celebre canzone (“Pastime with good company”), una vera hit di allora, che circolò come “La ballata del re”.
Pur non essendo un grande uomo d’armi, seppe scegliere con cura i suoi luogotenenti. Nel 1513 delegò al conte di Surrey il contrattacco all’invasione scozzese, il quale batté i nemici, uccidendo re Giacomo sul campo. Seguì il suocero, Ferdinando II D’Aragona, nella guerra contro la Francia e affidò a Thomas Wosley una campagna militare che fruttò popolarità a Enrico e soprattutto a Wolsey, nominato arcivescovo e lord cancelliere. La carriera di Wolsey, collaboratore e amico di Enrico, sembrò così brillante da fargli arrivare ad ambire il soglio pontificio. Del resto, lo stesso Enrico intratteneva ottimi rapporti con Roma. A parte la benedizione del matrimonio, quando nel 1519 l’Europa cominciò a essere percorsa dalla Riforma protestante, il re scrisse insieme a Wolsey e al suo cancelliere Thomas Moore (Tommaso Moro) un libello che affermava con forza il primato del Papa e il valore dei sette sacramenti, alcuni dei quali negati da Martin Lutero. Lo stesso Moore si mostrò sorpreso dell’intransigenza del sovrano, che in virtù del suo zelo venne nominato dal pontefice “Difensore della fede”.
Nel 1519 un avvenimento cambiò le sorti d’Europa: grazie a un’irripetibile politica matrimoniale, il Regno di Spagna, quello di Borgogna, e l’Austria furono concentrati nelle mani di un solo sovrano, Carlo V d’Asburgo. Nel 1521 il re divenne imperatore del Sacro Romano Impero e nel 1525, durante la battaglia di Pavia, la fanteria spagnola annientò l’esercito francese, catturando il re. L’equilibrio di forze era definitivamente cambiato e l’Inghilterra tolse il suo appoggio alla Spagna. Ma anche la politica interna stava mutando: in peggio. Nel 1523, Wolsey fu costretto a convocare il Parlamento per imporre ai nobili il pagamento delle tasse necessarie a scongiurare la bancarotta sfidandoli in un fallimentare braccio di ferro. Tutte le responsabilità del disastro – alcune tasse non solo non furono pagate ma vennero addirittura abolite – ricadde su Wolsey. Il re, del resto, sembrava assorto in tutt’altre questioni. Il problema del divorzio dominava incontrastato, almeno da quando Enrico aveva cominciato una relazione con la più famosa delle sue amanti, Anna Bolena.
Anna Bolena resta un personaggio leggendario: figlia di un nobile inglese, cresciuta in Francia, con un misto di arroganza ed eleganza seppe farsi largo tra le ammiratrici e le amanti del re, fino a conquistarne il cuore e diventare regina. Il matrimonio fu celebrato nel gennaio del 1533 e tenuto segreto fino al giorno di Pasqua, quando l’arcivescovo di Canterbury dichiarò annullato il matrimonio precedente. A nulla erano servire le pressione su Clemente VII, che si era rifiutato di acconsentire all’annullamento. Comprensibile: di mezzo, ci si era messo nientemeno che Carlo V, il nipote di quella Caterina d’Aragona, prima moglie di Enrico. Nel 1527, colpevole di aver ordito una lega antispagnola, del resto, il Papa era stato punito da Carlo con il Sacco di Roma e fatto prigioniero.
Le vicenda che portò alla definitiva rottura con la Chiesa cattolica fu costellata di episodi drammatici come l’esecuzione dei cancellieri Wolsey e Moore, sostituiti da Thomas Cromwell, duca di Essex, che ne guidò il compimento. Preso il controllo del concilio dei vescovi, Cromwell propose al sovrano la soluzione radicale dello scisma, che avrebbe permesso al re di prendere in sposa Anna Bolena, ma anche di riunire nelle sue mani un potere e ricchezze mai viste. La misura convinse il re, che pensò di poter disinnescare così in anticipo la Riforma protestante e risolvere i problemi delle disastrate finanze inglesi. La decisione del re venne così ratificata anche dal Parlamento con l’“Atto di supremazia” (1534). Facendo del re il vicario di Cristo sul suolo inglese, si consumava lo scisma anglicano. E a nulla valse la scomunica di Clemente VII.
Il terremoto scismatico ebbe immediate ripercussioni pratiche, tra cui l’annullamento del matrimonio. Ma la maturazione teologica richiese tempo: Enrico rimase convinto avversario di Lutero e ancora oggi la Chiesa anglicana porta le tracce del pensiero personale del sovrano inglese, fatta com’è di celibato e transustanziazione, ma anche del principio per cui l’uomo può salvarsi senza l’aiuto della Chiesa. Dal punto di vista economico, i vantaggi furono enormi: vennero smantellati gli oltre 800 monasteri e ne furono incamerate le ricchezze. Furono anni difficili, sia per la resistenza da parte del clero che per una politica crudele di Enrico nei confronti della nobiltà più riottosa. Perfino Cromwell, l’artefice dello scisma, venne imprigionato e giustiziato e si contano almeno altre 50 esecuzioni, compresa quella di Anna Bolena che, dopo la prima figlia Elisabetta, non diede alcun erede al re. Imprigionata nella torre di Londra con l’accusa di cospirazione, fu decapitata nel 1536.
Negli anni che seguirono Enrico si sposò altre quattro volte. Prima con una nobildonna inglese, Jane Seymour, dal cui matrimonio nacque il futuro Edoardo VI, ma che costò la vita a Jane subito dopo il parto. Poi ci fu un matrimonio d’interesse con una nobildonna tedesca protestante, Anna di Clèves, che non durò a lungo: Enrico si era già invaghito di una sua dama di compagnia, Caterina Howard, donna chiacchierata che intratteneva probabilmente già diverse relazioni quando convolò a nozze con re. Intemperanze che costarono la vita a lei e al suo amante. La sesta moglie fu Caterina Parr, una ricca vedova che, nonostante i dissapori con il re, riuscì a sopravvivergli. Alla morte del re, diventato mostruosamente sospettoso e obeso, si succedettero il figlio, una sorellastra e la figlia Maria che, fervente cattolica, abolì l’Atto di supremazia, facendo vacillare la riforma anglicana. La svolta arrivò nel 1558, quando salì al trono Elisabetta I, la figlia di Enrico e Anna Bolena. La regina non solo inaugurò una stagione mirabile per il suo Paese – l’età di Shakespeare, per capirci – ma ristabilì l’eredità religiosa del padre: sotto il suo regno, fu riaffermato l’“Atto di supremazia” (1563) e, nonostante i ciclici sussulti cattolici, l’isola assunse in modo definitivo la fisionomia religiosa che ancor’oggi conosciamo.