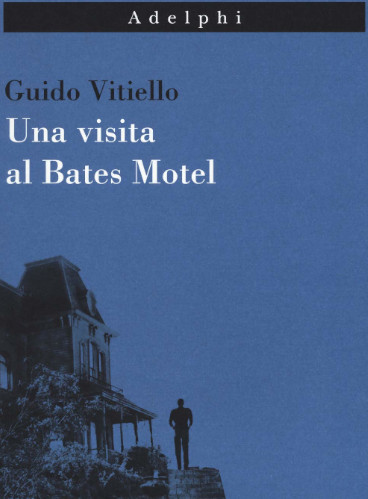31/10/1984 • Moriva 36 anni fa un gigante del teatro. Dagli esordi alla rottura con Peppino al patrimonio lasciato alla tv
“Puó’ dí ch’ ’e strade ’e Napule cheste só’: nu palcoscenico”, cantava Sergio Bruni, “A voce ’e Napule”. La teatralità dei napoletani, si sa, è un luogo comune non lontano dal vero. Loro stessi ce lo ricordano: a gesti, a parole e con l’inconfondibile inflessione della voce. Se da Port’Alba, poi, s’imbocca lo stretto vicolo dei librai, ci si perde tra le montagne di volumi sul teatro, tantissimi dedicati proprio a chi scrisse che Bruni era la voce di Napoli e – riportando quel che si diceva, beninteso! – aggiungeva: “’A ggente sà che dice? (…) Ca Napule songh’io!”. No, non è Maradona, di cui comunque esistono murales, reliquiari ed edicole sparsi per la città. È Eduardo de Filippo, che non a Napoli ma a Roma morì un mercoledì di 36 anni fa.
Eduardo, però, in un certo senso, vive ancora. Vive nel teatro che fece ricostruire, il San Ferdinando; vive nelle rassegne che lo ricordano; nelle teche Rai e su Rai-Play; vive in molti rifacimenti filmici delle sue commedie, come “Il sindaco del rione Sanità” (2019), diretto da Mario Martone. Se, dopo la morte, si pensava che il suo teatro si sarebbe appannato, così non è stato: Eduardo de Filippo resta non solo il santo laico del teatro napoletano, ma un’icona irrinunciabile e riconoscibile – smilzo, con le sue guance scavate e spigolose – del Novecento italiano.
Eduardo nacque nel 1900, a Napoli, nel quartiere di Chiaia. Era figlio illegittimo dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta, divo del teatro napoletano, ma anche interprete della doppia morale delle classi agiate di allora: manteneva ben tre, forse quattro famiglie. Una di queste era quella dei De Filippo, composta dalla madre di Eduardo, Luisa, e dai suoi due fratelli, Annunziata e Giuseppe, ribattezzati Titina e Peppino. “Una famiglia difficile”, ebbe a scrivere Peppino, alla quale, nonostante tutto, Scarpetta diede un futuro. Per i tre fratelli il teatro fu una scelta obbligata: entrarono piccolissimi nella compagnia del padre, passata poi sotto la direzione del fratellastro, Vincenzo. Eduardo esordì sul palcoscenico all’età di soli quattro anni, portato in braccio da un attore.
I tre De Filippo si dimostrarono attori capaci. A vent’anni, già vantavano delle “serate d’onore”, rassegne antologiche dei loro personaggi più apprezzati. Decisero quindi di mettersi in proprio. Esordirono con “SikSik, l’artefice magico” (Peppino apostrofava così il fratello: “sicc sicc”, cioè “secco secco”, magro); un successo, ma nulla di paragonabile a quanto accadde dopo quel 25 dicembre 1931, quando al Teatro Kursaal di Napoli andò in scena “Natale in casa Cupiello”. La commedia, che sarebbe dovuta restare in cartellone nove giorni, ci restò per nove mesi. Ora: a Napoli, il Natale ma, soprattutto, il presepe (un protagonista della storia) è una cosa molto seria, nel quale i personaggi – come accade per la smorfia – costituiscono un sistema intricato di simboli. Ma, evidentemente, dietro il folklore c’era di più: i De Filippo avevano toccato le corde di una città intera. “Te piace ’o presepe?”, chiede Luca Cupiello al figlio. E lui gli risponde, sempre, invece: “No, nun me piace!”.
Il successo di “Natale in casa Cupiello” fece conoscere i De Filippo all’Italia intera, conquistando perfino le simpatie di Mussolini. È in quegli anni che Eduardo cominciò a maturare l’ambizione di diventare un grande autore. Sono gli anni, infatti, della collaborazione con Silvio D’Amico, fondatore dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e col maggiore drammaturgo italiano di allora, Luigi Pirandello, senza che però ne uscisse nulla di significativo. Anzi: “L’abito nuovo”, scritto a quattro mani, fu giudicato dallo scrittore Corrado Alvaro non all’altezza dei due autori. E ancora oggi, un critico contemporaneo come Maurizio Giammusso la definisce “l’opera più brutta di entrambi”. Quando arrivò la guerra, Eduardo si era già da qualche anno trasferito a Roma.
Dopo la liberazione, decise di tornare a Napoli. Alla città che era eroicamente insorta contro i tedeschi, però, se n’era sostituita un’altra, piena di rovine e fame, dominata dal mercato nero e dalla prostituzione. C’è un episodio mitologico, a questo punto, un incontro tra Eduardo e lo scrittore Curzio Malaparte, in quella Napoli disastrata. La leggenda vuole che da quell’incontro nacquero due capolavori. Malaparte cominciò a scrivere “La pelle”. Eduardo, invece, andò in scena il 15 marzo del 1945 al San Carlo, con uno spettacolo in favore della Croce Rossa. Era “Napoli milionaria!”. La commedia è il racconto di un reduce che, tornato dalla guerra, trova una situazione familiare disastrosa: una moglie dedita al mercato nero e fedifraga; una figlia incinta di un soldato americano; un figlio delinquente. La sgangherata famiglia riesce a trovare unità solo quando la figlia più piccola si ammala; ma la cura è affidata a una medicina che non si sa se la salverà. Come recita l’ultima, leggendaria battuta “Ha da passà ’a nuttata” (scritta così nel copione, ma che a tutti suona come “Adda passà ’a nuttata”). Di quella prima rappresentazione, scrisse Eduardo: “Arrivai al terzo atto con sgomento. Recitavo e sentivo attorno a me un silenzio assoluto, terribile. Quando dissi l’ultima battuta finale e scese il pesante velario, ci fu silenzio per otto, dieci secondi. Poi, scoppiò un applauso furioso e anche un pianto irrefrenabile. Tutti avevano in mano un fazzoletto: gli orchestrali che si erano alzati in piedi, i macchinisti che avevano invaso la scena e il pubblico, che era salito sul palco. Tutti piangevano, e anch’io piangevano. Io avevo detto il dolore di tutti”.
Appena un anno dopo, Eduardo scrisse “Filumena Marturano”, pensata su misura per la sorella Titina. Le battute recitate dalla sorella – “I figli so’ figli” o “Quant’è bello chiagnere” – le sognò di pronunciare, tra le tante, senza mai riuscirci, anche una super diva come Anna Magnani. Quando morì Titina, uno dei primi ad arrivare al capezzale fu il fratello Peppino, che nel frattempo aveva lasciato la compagnia ed era assurto alla fama come la migliore delle spalle di Totò. Ma i due fratelli già da tempo non si parlavano: i rapporti si erano rotti irreparabilmente nel 1944 e, da allora, si scrivevano solo per lettera.
La famiglia, già: un chiodo fisso di Eduardo, a cui dedicò un trittico culminato con un altro capolavoro, “Sabato, domenica e lunedì”, sfiorando – qualcuno scrisse – Anton Čechov. La vita di Eduardo fu lunga, costellata di molti successi professionali, perfino all’estero (a Londra e in Russia) e, in fondo, da pochi scivoloni, spesso fuori dal suo controllo, come un film mancato con Fellini e un fiasco negli Usa, imputabile per molti alla regia affidata a Franco Zeffirelli. Il lutto più duro che dovette affrontare fu la morte improvvisa della figlia Luisella, di quattro anni, per un aneurisma, mentre giocava col fratello Luca.
Con l’arrivo della televisione, Eduardo registrò una gran quantità di commedie, lasciandoci un patrimonio inestimabile. Senza dubbio, lo fece anche per apporvi, con la sua interpretazione, il proprio sigillo. Menzioniamo, su due piedi, almeno due cose da rivedere: il film che Zeffirelli dedicò a Pulcinella, dove Eduardo, dietro la maschera, sa trasmettere un’incredibile gamma di emozioni; ma anche la scena di “Questi fantasmi”, dove racconta dal balcone la ricetta perfetta del caffè napoletano.
«È stata tutta una vita di sacrifici. E di gelo: così si fa il teatro. Così ho fatto. Ma il cuore ha tremato sempre, tutte le sere, tutte le prime rappresentazioni. E l’ho pagato. Anche stasera batte. E continuerà a battere, anche quando si sarà fermato», disse così a Taormina, ritirando un premio, poco prima di morire. Ma non dopo aver ringraziato, pubblicamente e con parole commoventi, il figlio Luca, che lo aveva accompagnato negli ultimi anni della sua vita professionale. Nel cuore, in questo momento, ci resta forse più di tutte quella battuta di “Napoli milionaria!”, “Adda passà ’a nuttata”.
Ma Eduardo sembra ci parli ancora, forse più di prima e forse proprio a noi. In una delle ultime rappresentazioni, infatti, decise di cambiarla, quella battuta. E, dunque, prima che il sipario cali, non dice di dover aspettare che passi la notte, “Adda passà ’a nuttata”, ma “’A guerra nun è fernuta”: “La guerra non è finita”.
Federico Pani
Il Piccolo di Cremona, 31 ottobre 2020