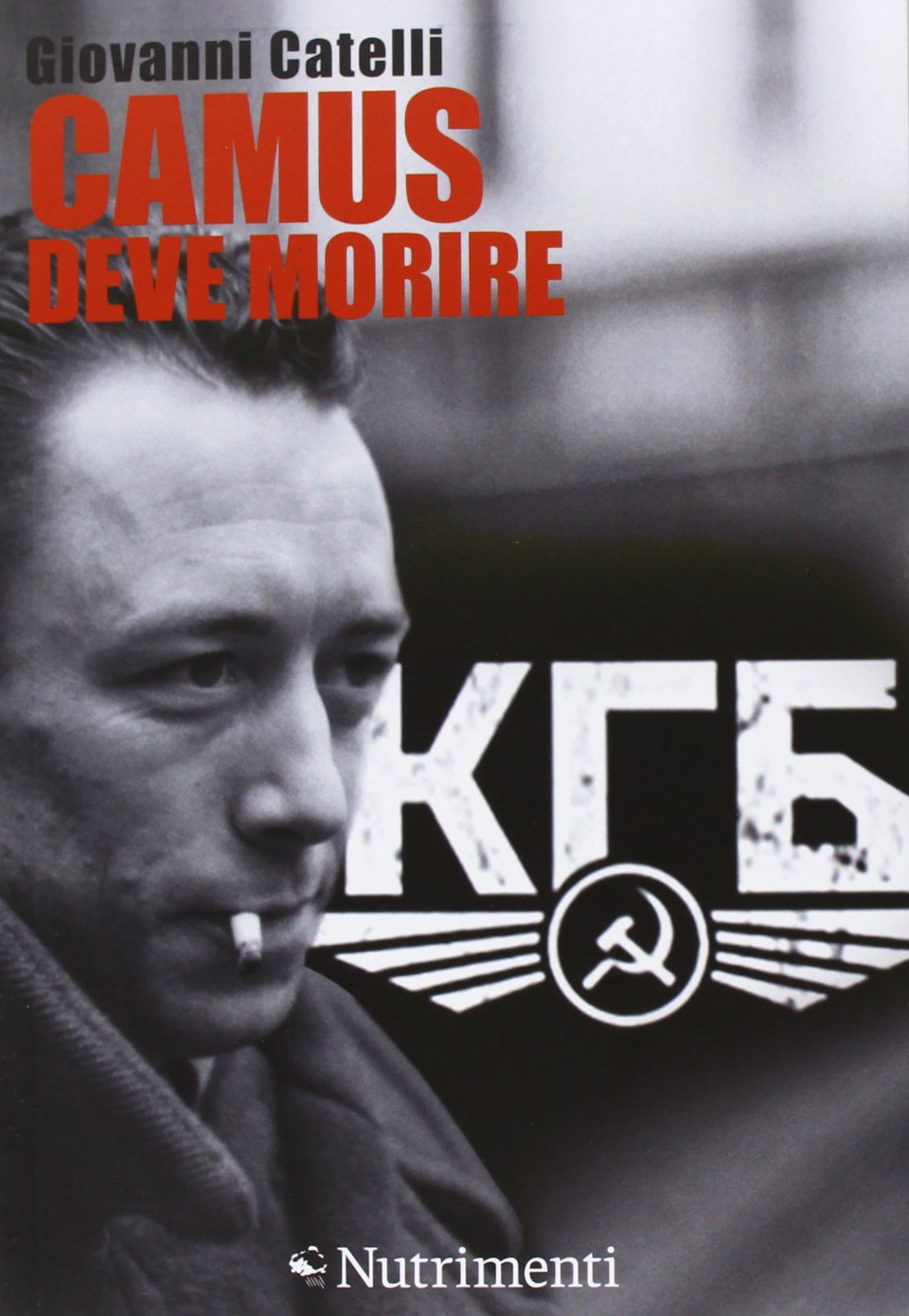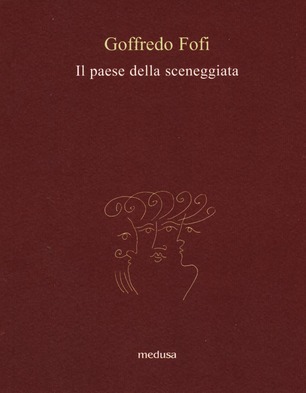Peccato per le virgolette, disseminate un po’ in tutto il libro: sono tra le poche cose, forse le uniche, che si possono rimproverare alla prosa di Giovanni Raboni (1932-2004), poeta della scuola lombarda, traduttore di Proust e, in questo libro, critico militante. Parliamo della raccolta edita da Mondadori “Meglio star zitti?” (15 euro, pp. 480). Ecco, provate a togliere le virgolette e la sua scrittura non perderà nulla. Nemmeno quel tratto esitante, frutto (a detta del curatore Luca Daino) degli studi filosofici in fenomenologia, di cui per fortuna non rimane nessun’altra traccia. Più che recensioni, sono stroncature. Di libri, di film e di spettacoli di teatro. Ma sarebbe stato riduttivo chiamarle così.
Ogni articolo, in effetti, dosa le ragioni di approvazione e di disappunto; qualche volta anzi capita che la partita finisca alla pari. In molte di esse, comunque, la scelta delle parole è tale da farci percepire, oltre all’esercizio di equilibrio, la professione di Raboni, cioè quella di poeta: “Ogni morte è una sorta di profezia a rovescio, ci mette sulle tracce di quello che è già successo (di una parola che è già stata detta) e che di colpo diventa, ai nostri occhi, un segno, un segnale”. Come è accaduto, per esempio, ai versi di Alexandros Panagulis, il poeta e rivoluzionario greco compagno di Oriana Fallaci: “poveri versi impacciati e retorici” a cui “la morte ha restituito lo spessore della realtà (la realtà delle celle d’isolamento, degli scioperi della fame, delle torture) perforando lo specchio cieco o deformante degli ingenui artifici stilistici”.
Il libro, che è di rara scorrevolezza, può essere letto di seguito o spigolato all’occorrenza. E, c’è da confessarlo, in alcune pagine si prova tutto il piacere liberatorio della stroncatura. Una delle migliori riguarda Va’ dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro:
Che può mai fare una rosa in giardino? È chiaro: spiccare “con il suo color porpora, solitaria ed arrogante, sul resto della vegetazione”. E un cane quando vede comparire la padrona? Non c’è il minimo dubbio: “mettersi a correre in tondo come un pazzo”. Quanto alle cose, va da sé, che “non sono mai state così semplici, non sono mai o nere o bianche” (…). Nessuno è disposto a sorbirsi 165 pagine di fatterelli minutamente prevedibili per poi sentirsi dire come premio finale, che “se la vita è un percorso, è un percorso che si svolge sempre in salita” e che “l’unico maestro che esiste, l’unico vero e credibile è la propria coscienza”.
In generale, intessendo il suo discorso di citazioni e riferimenti, Raboni dà sì un’idea generale delle opere che recensisce; ma soprattutto si sforza di giustificarne il giudizio. Come lui stesso pensava, infatti, è proprio del giudizio che ogni recensore deve rendere conto al lettore. Pur negli spazi angusti che ha. E va detto: siamo ancora molti a dover imparare che nessuna saccenteria, anche involontaria, rende un giudizio più autorevole – la pur grande Grazia Cherchi scriveva: “Leggete questo, fidatevi di me”, anche se, almeno, offriva sul piatto il suo gusto critico. “Meglio star zitti?” serve a impararlo. Perché, pur essendo anche lui in qualche caso sbrigativo (sarà vero, come dice, che Pasolini è poeta solo quando scrive in prosa?), Raboni dimostra di saperlo fare.
Cafè Golem, 8 gennaio 2020