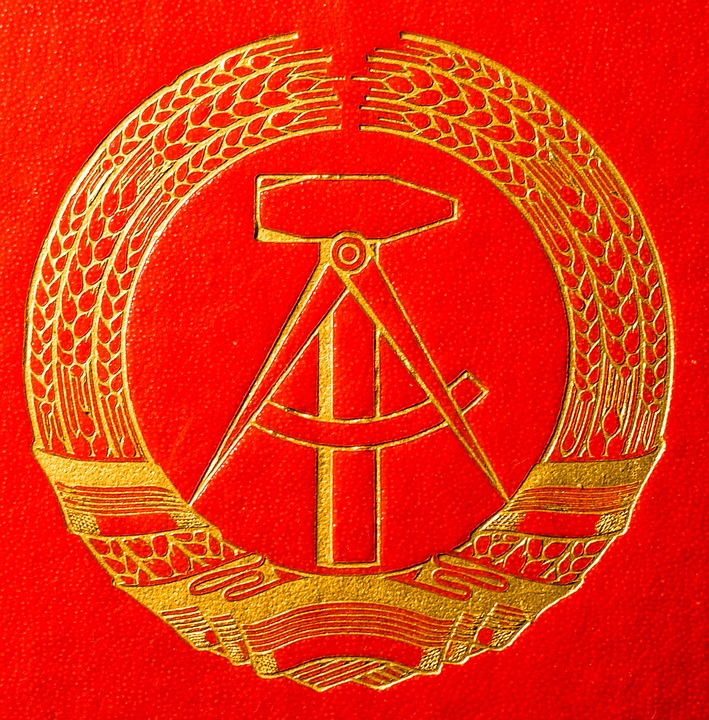28/11/1520 • Oggi 500° anniversario di un’avventura lunga tre anni raccontata dall’italiano Antonio Pigafetta, che fu tra i pochi sopravvissuti
“Mercore a 28 de novembre 1520 ne disbucassemo da questo stretto s’ingolfandone [nel] mar Pacifico”. Con queste parole, Antonio Pigafetta descrive l’inizio del viaggio nel “mare” Pacifico, una delle tappe che lo avrebbero condotto al primo giro intorno al globo compiuto dall’umanità. Ma a smorzare quest’atmosfera da sogno, fatta di vento e salsedine, è lo stesso Pigafetta: “Stessemo tre mesi e venti giorni senza pigliare refrigerio di sorta alcuna. Mangiavamo biscotto, non più biscotto, ma polvere de quello con vermi a pugnate, perché essi avevano mangiato il buono: puzzava grandemente de orina de sorci, e bevevamo acqua gialla già putrefatta per molti giorni, e mangiavamo certe pelle de bove (…) durissime per il sole, pioggia e vento”.
La vita in mare doveva essere qualcosa di spaventosamente difficile, allora. Ma ciò non aveva dissuaso il vicentino Antonio Pigafetta dall’imbarcarsi in quel viaggio. Era partito dal porto fluviale di Siviglia il 10 agosto del 1519 in qualità di aiutante di bordo del capitano portoghese Ferdinando Magellano. Ma cosa ci facevano un portoghese e un italiano a bordo di una flotta di cinque navi battenti bandiera spagnola?
Ferdinando Magellano era un nobile portoghese, datosi alla carriera marittima per cercare gloria e ricchezze, cresciuto nel mito delle imprese di Vasco de Gama, l’ammiraglio che, per primo, aveva raggiunto l’India (1497-98), doppiando il Capo di Buona Speranza. Enormi ricchezze attendevano chi si fosse spinto in quegli angoli remoti del mondo, dove i portoghesi già cominciavano a disseminare i loro empori commerciali. Reduce di molti viaggi (uno dei quali perfino in Malesia), dopo un’impresa militare condotta in Marocco (la presa di Azemmour), Magellano era però caduto in disgrazia: accusato di furto, era stato allontanato dalla corte lusitana.
Antonio Pigafetta era invece un nobile vicentino, finito nella Spagna del tempo al seguito di una delegazione pontificia. Cavaliere dell’Ordine di Rodi, doveva forse a questo la propria esperienza navale. A bordo della flotta di Magellano vi finì un po’ per caso: era stata una soluzione di compromesso tra la richiesta del capitano di poter essere affiancato da un aiutante di campo portoghese e il rifiuto da parte degli spagnoli.
Magellano si era presentato alla corte di Carlo re di Spagna con una proposta straordinaria ma non certo originale: raggiungere le Indie passando da ovest. “Buscar el Levante por el Poniente” (raggiungere l’Oriente passando per l’Occidente), proprio come si era messo in testa di fare un altro capitano, genovese, nemmeno trent’anni prima. Ma dai tempi di Cristoforo Colombo, di mezzo ci si erano messi un continente intero e un nuovo mare. Le promesse di Magellano rasentavano l’incredibile: impadronirsi delle Molucche, isole di favolosa ricchezza assegnate al Portogallo. In che modo? Dimostrando che le isole si trovavano nella parte di mondo spettante alla Spagna, secondo gli accordi internazionali stipulati qualche anno prima.
Ma qual era la ricchezza tanto promessa? Non oro, né argento, bensì spezie: pepe, chiodi di garofano, noce moscata.
Per noi contemporanei resta inspiegabile il fatto che si intraprendessero viaggi così pericolosi per beni dei quali, spesso e volentieri, oggi facciamo benissimo a meno. Come ha spiegato Alessandro Barbero: “La civiltà tardo medievale era una civiltà senza tè, caffè, tabacco, liquori: le spezie erano l’unica cosa che potevano dare un sapore piccante alla vita. Poter accompagnare i cibi con le spezie (usate peraltro anche nella medicina e nel settore tessile come coloranti) conferiva immediatamente un rango più elevato. E, del resto, se si guarda il peso al chilo, anche oggi valgono più dell’oro. Una sola nave carica di spezie poteva fare la fortuna di un’intera compagnia commerciale”.
Nonostante ciò, l’impresa di Magellano rasentava l’incoscienza. Il continente americano era stato esplorato solo in minima parte (il conquistador Hernán Cortés era partito alla volta del Messico, giusto pochi mesi prima di Magellano). Si sapeva che il continente proseguiva verso sud, ma non c’era prova che i due mari fossero tra loro comunicanti. Il navigatore italiano Amerigo Vespucci, che battezzò il continente con il suo nome e pubblicò nel 1503 la migliore carta in circolazione del Nuovo Mondo, aveva raggiunto i confini settentrionali dell’attuale Argentina, senza però essersi spinto oltre.
Il viaggio di Magellano trovò le prime difficoltà dopo pochi mesi. Oltre le coste del Brasile, nessuno sapeva cosa aspettarsi. Ogni insenatura poteva rivelarsi l’agognato passaggio verso l’oriente. Fu così per il Río de la Plata e infinite altre foci di fiumi, scambiati per stretti. La frustrazione degli equipaggi culminò in un ammutinamento, sedato a fatica da Magellano, che abbandonò il capitano in seconda, Juan de Cartagena, sulle rive della Patagonia, come esempio per tutta la ciurma. Le cose, tuttavia, peggiorarono ancora: una nave fu persa durante l’esplorazione della costa; un’altra, col favore della notte, girò le vele e se tornò in Spagna.
Poi, arrivò la svolta: un golfo nel quale si apriva un’insenatura, un’altra ancora e così via. E l’acqua continuava a essere salata. Magellano imboccò con decisione quello stretto, che prese poi il suo nome, e che lo condusse quel 28 novembre di 500 anni fa ad avvistare il “mare” Pacifico. Le difficoltà non finirono. Davanti alle navi si aprì la distesa immensa e interminabile dell’Oceano. Sinistre malattie avanzavano nell’equipaggio, facendone strage: “Crescevano le gengive ad alcuni sopra li denti così de sotto come de sovra, che per modo alcuno non potevano mangiare, e così morivano dieci per questa infermità”.
Passavano le settimane e nulla accadeva, mentre le provviste e l’equipaggio si assottigliavano inesorabilmente. Scrive Pigafetta: “In questi tre mesi e venti giorni andassemo circa de quattro mila leghe per questo mar Pacifico (in vero è bene pacifico, perché in questo tempo non avessimo fortuna) senza vedere terra alcuna, se non due isolotte disabitate. (…) E se Iddio e la sua Madre benedetta non ne dava così buon tempo, morivamo tutti de fame in questo mare grandissimo”.
Finalmente, la flotta raggiunse le isole dell’Indo pacifico, approdando nelle attuali Filippine. Magellano aveva raggiunto il suo primo obiettivo. Cominciò allora a elaborare il suo piano di conquista, cercando di convertire a forza i nativi e stringendo alleanze con alcuni regni locali. L’intrusione non piacque a molti di quei sovrani, che si organizzarono per sbarazzarsi degli intrusi. Nella battaglia di Mactan, centinaia di locali si avventarono sulle poche decine di europei. La resistenza fu disperata e lo stesso Magellano cadde. Così Pigafetta: “Uno Indio li lanciò una lanza de canna nel viso. Lui subito con la sua lancia lo ammazzò e lasciagliela nel corpo; volendo dar di mano alla spada, non poté cavarla, se non mezza per una ferita de canna [che] aveva nel brazzo. Quando visteno questo tutti andarono addosso a lui: uno con un gran terciado (che è como una scimitarra, ma più grosso), li dette una ferita nella gamba sinistra, per la quale cascò col volto innanzi. Subito li furono addosso con lancie de ferro e de canna e con quelli sui terciadi, fin che lo specchio, il lume, el conforto e la vera guida nostra ammazzarono”.
Scossi dall’avvenimento, ma non piegati, i superstiti proseguirono fino alle Molucche, dove riuscirono a fare rifornimento di spezie. Delle tre navi rimaste, una fu abbandonata, perché l’equipaggio era ormai troppo ridotto per potersene occupare. Le due rimanenti si divisero e cominciarono a fare vela verso la Spagna. Le insidie, però, non erano finite: il re del Portogallo aveva ordinato alla sua flotta di intercettare le navi spagnole, essendo venuto a conoscenza del loro arrivo. Una delle due navi venne catturata. L’altra, la Victoria, guidata da Juan Sebastián Elcano raggiunse finalmente la Spagna: “Sabato, a sei de settembre 1522, intrassemo nella baia de San Lucar, se non disdotto uomini e la maggior parte infermi”. Diciotto sugli oltre duecentosessanta che erano partiti più di tre anni prima.
Il resoconto di quel viaggio, “Il primo viaggio intorno al globo”, venne scritto da Pigafetta solo qualche anno dopo e pubblicato postumo. Monumento eccezionale della letteratura marinara, nonostante l’italiano incerto e arcaico, vi coabitano la narrazione avventurosa ma sincera di quei giorni e preziose testimonianze sugli usi e costumi delle popolazioni incontrate, corredate perfino da piccoli vocabolari. È lui, Pigafetta, con il suo resoconto, in fondo, l’eroe di questa spedizione, per molti versi fallimentare: dimostrò che la via più sicura per le Indie restava quella passante dal Capo di Buona Speranza, ben rodata dai portoghesi; e che rompere il loro monopolio sarebbe stato eccezionalmente difficile (ci riuscirono gli olandesi, ma quasi cent’anni dopo). Resta però il fatto che quel viaggio fu epocale: rappresentò uno dei gradi passi che gli europei fecero nella modernità e che li destinarono alla conquista di buona parte del mondo.
Federico Pani
Il Piccolo di Cremona, 28 novembre 2020